a cura di R. Centis
Come sempre, mi piace iniziare da alcune definizioni.
Cito da: Glossario O.M.S. della Promozione della Salute, pag 29 (L’ Health Promotion Glossary è disponibile on line al seguente indirizzo http://www.who.int/healthpromotion/about/HPG/en/):
Per raggiungere questo obiettivi sono necessari diversi fattori che si articolano reciprocamente, e vanno dal livello individuale al livello sociale-politico. Uno di questi, partendo dal livello individuale, si riferisce al concetto di “cura”.
Cura: la prima definizione data dal Vocabolario Treccani è: “Interessamento solerte e premuroso per un oggetto, che impegna sia il nostro animo sia la nostra attività”.
Questa affermazione, per quanto generica, si adatta molto bene alle professioni sanitarie: tutte le figure che appartengono al mondo della salute sono in qualche modo, specifico per ogni profilo professionale, coinvolte nella cura delle persone. Ma cosa significa “cura” in questo campo? Nella lingua inglese troviamo una distinzione semantica espressa dai verbi: “to cure”, che significa “curare” e “to care” che significa “prendersi cura” ma in italiano spetta ad ognuno scegliere quale versante del significato privilegiare.
Qual è una caratteristica fondamentale dell’azione di cura, nel senso di “prendersi cura”?
L’essere affetto da una malattia “inguaribile” non coincide con il trovarsi in una condizione “incurabile”, perché è sempre possibile prendersi cura di una persona affetta da malattia, sia acuta, guaribile, sia cronica ed evolutiva, o da disabilità. In queste condizioni emergono domande fondamentali sul “perché?”, “perché io?”, sul senso delle esperienze a volte drammatiche che si è costretti ad attraversare. In questi casi assumono fondamentale importanza le relazioni di cura che sostengano la libertà del malato nella ricerca del significato e dell’essenziale, favorendo il cammino di una ricerca, che può favorire accettazione dell’istante presente, e fioritura di una speranza pur dentro ad un limite.

L’esperienza della sofferenza necessita di qualcuno che condivida, indica il bisogno di una pazienza, di una vicinanza e di una attenzione, che da un livello strettamente individuale, raggiunga anche la dimensione sociale del progetto politico e della realizzazione di opere.
“Godere del più alto standard di salute raggiungibile é uno dei diritti fondamentali di ogni essere umano senza distinzione di razza, religione, credo politico, condizione economica o sociale”.
Nel glossario OMS, alla voce “salute” viene affermato:
“Oggi viene riconosciuta sempre di più la dimensione spirituale della salute. Essendo considerata dall’OMS un diritto umano fondamentale, tutte le persone dovrebbero avere accesso alle risorse basilari per la salute”.
Questi aspetti, appannaggio privilegiato delle professioni infermieristiche, coinvolgono profondamente la funzione del medico che si trova di fronte alla sofferenza, alla morte, alla paura della morte.
Ogni periodo storico sviluppa i propri metodi per fronteggiare la paura della morte. Nel corso dei secoli noi umani abbiamo sviluppato un’enorme varietà di strategie, alcune consce, altre inconsce per contrastarla. Alcuni metodi funzionano, altri sono incerti, inefficaci, a seconda della persona con cui siamo in relazione, al suo carattere, alle sue esperienze passate, alle sue credenze. Quando questi non sono sufficienti, di solito le persone si rapportano alla morte attraverso la negazione, la diversione, o la rimozione.
In passato, nelle culture europee e occidentali la morte era più visibile per l’alto tasso di mortalità di donne e bambini e chi stava per morire non veniva sequestrato come accade oggi, in un letto d’ospedale schermato da tende protettive e relegato da solo nella propria esperienza di addio, o peggio ancora, come abbiamo sperimentato in tempi non lontani, durante la recente pandemia, risucchiato in un nulla senza connotati, restituito alla famiglia come informazione asettica di decesso, senza poter elaborare alcun processo di separazione.

Come accade nelle guerre. O comunque, se anche lo sviluppo di malattia non conduce alla fase terminale, sono note a tutti le esperienze drammatiche di barelle ammassate nei corridoi dei reparti di emergenza, recanti individui in vario stato di degrado psico – fisico, a volte senza una assistenza minimale se non quella per garantire la pura sopravvivenza. In passato la maggior parte della gente moriva in casa, con i membri della famiglia presenti al momento dell’ultimo respiro.
Noi tutti esseri umani siamo programmati per entrare in relazione con gli altri. Da qualsiasi prospettiva si studi la società umana, si tratti della sua lunga storia evoluzionistica o dello sviluppo di un singolo individuo, siamo obbligati a considerare l’essere umano nel proprio contesto interpersonale, in quanto relazionato con gli altri. La solitudine aumenta notevolmente l’angoscia di dover morire: troppo spesso la nostra cultura crea una cortina di silenzio. Amici e familiari spesso prendono le distanze perché non sanno che cosa dire per paura di turbare il morente ed evitano di avvicinarsi troppo anche perché temono di doversi confrontare personalmente con la propria morte. E questo triste fenomeno, questa incompetenza relazionale che caratterizza la nostra società non lascia indenni gli operatori sanitari, in primis i medici. Posti di fronte all’ineluttabile, sperimentiamo un senso di impotenza che può diventare personalmente devastante. Ecco che quindi molti si difendono barricandosi dietro il cinismo, il distanziamento, la risposta tecnologica a tutti i costi.
Ma uno strumento potente che abbiamo per provare a connetterci con le altre persone, è l’empatia, collante della connessione umana che ci permette di sentire, a livello profondo, ciò che un altro sta provando e può creare uno spazio di interconnessione in cui lo scambio, il dono, la consolazione è reciproca.
E oltre l’empatia, la presenza, la nostra presenza. La semplice presenza ha potere. Presenza é “essere proprio lì”.

Il dono più grande che possiamo offrire a qualcuno che accompagniamo e che si trova a fronteggiare la morte è la propria pura e semplice presenza, attenta e non manipolatrice. Una presenza umana salda e sicura che desidera stare con qualsiasi cosa emerga è un fattore potentissimo. Si può tenere compagnia a qualcosa, dentro, che è “troppo dolente, troppo sgomentante o angosciante” per essere espresso e aiutare così la consapevolezza personale fino al punto in cui la persona è in grado di gestirla, o decide di continuare il suo percorso interiore.
Nella mia osservazione, sviluppatasi negli anni, e anche nella mia esperienza personale, ho spesso notato che la sofferenza che bisogna fronteggiare ha quindi un duplice risvolto: non appartiene solo alla persona ammalata, ma una parte appartiene al medico stesso, che non ha strumenti adeguati per lavorare bene, si rende conto di non fare ciò di cui il paziente ha bisogno, e vive l’angoscia di essere impotente o quanto meno inadeguato, ne soffre e a volte ciò si configura anche in un conflitto morale. Il conflitto nasce quando l’imperativo interiore suggerisce una linea di condotta, fa percepire una responsabilità a cui però non si può rispondere perché ci sono condizioni interne – come il non avere una formazione adeguata o dover affrontare situazioni gravi, potenzialmente traumatiche senza aver potuto effettuare una sufficiente elaborazione personale – o esterne – stanchezza da turni soverchianti, assedio del carico burocratico, eccesso di richieste di prestazioni, limitazioni alla libertà professionale, carenza di strutture diagnostico–degenziali, carenza di tempo, limitazioni ambientali ecc – che impediscono una armoniosa capacità di risposta ai bisogni.

In questo caso, tanto il paziente, quanto il professionista percepiscono il deterioramento della propria centralità relazionale e si sentono diventare oggetti in balia di meccanismi controllanti e incontrollabili; il medico perde la propria autonomia e creatività professionale fino al punto di avere come meta prioritaria la conclusione della propria attività.
Poiché questa esperienza è largamente condivisa da ampi strati di popolazione e larghe quote di medici sono sottoposti allo stress di veder progressivamente impoverirsi il primitivo entusiasmo che li aveva spinti ad abbracciare una professione così intensa, pregnante e indubbiamente soddisfacente se vissuta nella sua pienezza, è doveroso chiedersi come mai ci troviamo in questa situazione che sembra progredire verso un degrado sempre più profondo … gli organi preposti alla difesa della qualità non hanno dimostrato la volontà o la capacità di difendere la relazione di cura, così che fosse più umana sia per i pazienti che per i medici, basata su fiducia, scienza e coscienza.

E’ doveroso interrogarci sulle cause, cercare possibili correttivi, soluzioni, individuare responsabilità e criticità, impostare percorsi di cambiamento che permettano spazi di vita e di recupero di integrazione personale, creare le condizioni perché si possano realizzare strategie innovative per promuovere una cultura della prevenzione e della cura, garantendo una migliore qualità della vita e una maggiore sostenibilità del sistema sanitario.
















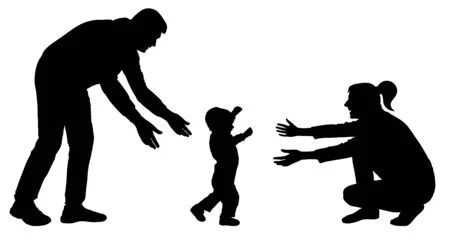
















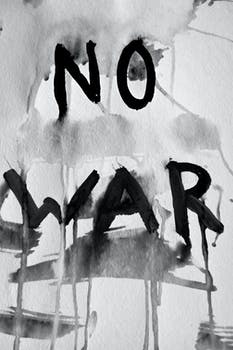


























Lascia un commento